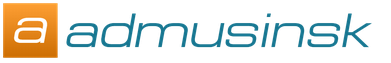Nomi dei sali.
Se un metallo ha valenza variabile, viene indicato dopo l'elemento chimico con un numero romano racchiuso tra parentesi. Ad esempio, CuSO 4 è solfato di rame (II).
Compito n. 2.
Condizioni per completare l'attività:
Compito n. 2. Disegna diagrammi elettronici della struttura degli ioni Na +, Ca 2+, Fe 3+.
Compito n. 1. Tipi di sistemi dispersi. Classificazione delle soluzioni.
Compito n. 2. Indicare le caratteristiche della struttura elettronica degli atomi di rame (n. 28), cromo (n. 24).
Compito n. 1 .
Tipi di sistemi dispersi
Un sistema disperso è un sistema in cui una sostanza è finemente suddivisa in un'altra sostanza.
La fase dispersa è una sostanza frantumata.
Il mezzo di dispersione è una sostanza in cui è distribuita la fase dispersa.
In base al loro stato di aggregazione si distinguono:
– impianti gas (aria);
– sistemi solidi (leghe metalliche);
– liquido (mezzo di dispersione - acqua, benzene, alcool etilico).
Un sistema omogeneo solido o liquido costituito da 2 o più componenti è chiamato soluzione.
Il soluto è uniformemente distribuito sotto forma di molecole, atomi o ioni in un altro solvente.
A seconda della dimensione delle particelle disciolte, si distinguono:
1. Sistemi dispersi grossolani:
– sospensioni - fase solida dispersa (soluzione di argilla);
– emulsioni - fase liquida dispersa (latte).
2. Soluzioni colloidali (sol) - costituite da particelle molto piccole (10 -5 - 10 -7 cm), distribuite uniformemente in qualsiasi mezzo:
– in acqua (idrosol),
– in liquidi organici (organosoli),
– nell'aria o in altri gas (aerosol).
I sol occupano una posizione intermedia tra le soluzioni vere e i sistemi grossolani.
3. Soluzioni vere: soluzioni in cui le particelle non possono essere rilevate otticamente.
Diametro delle particelle disperse in I.r. meno di 10-7 cm.
Le soluzioni liquide sono costituite da un soluto, un solvente e i prodotti della loro interazione.
Compito n. 2. Indicare le caratteristiche della struttura elettronica degli atomi di rame (n. 28), cromo (n. 24).

Diagrammi energetici dei sottolivelli di valenza degli atomi di cromo e rame.
L'atomo di cromo ne ha 4 S-non ci sono due sottolivelli, come ci si aspetterebbe, ma un solo elettrone. Ma alle 3 D-il sottolivello ha cinque elettroni, ma questo sottolivello si riempie dopo 4 S-sottolivello. Ognuno dei cinque 3 D-le nuvole in questo caso sono formate da un elettrone. La nuvola elettronica totale di questi cinque elettroni ha una forma sferica o, come si suol dire, sfericamente simmetrica. Per la natura della distribuzione della densità elettronica in diverse direzioni, è simile a 1 S-EO. L'energia del sottolivello i cui elettroni formano una tale nuvola risulta essere inferiore rispetto al caso di una nuvola meno simmetrica. In questo caso, l'energia orbitale è 3 D-il sottolivello è uguale all'energia 4 S-orbitali. Quando la simmetria viene rotta, ad esempio quando appare il sesto elettrone, l'energia degli orbitali è 3 D-il sottolivello diventa nuovamente maggiore dell'energia 4 S-orbitali. Pertanto, l'atomo di manganese ha nuovamente un secondo elettrone in 4 S-AO. La nuvola generale di qualsiasi sottolivello, piena di elettroni per metà o completamente, ha simmetria sferica. La diminuzione di energia in questi casi è di carattere generale e non dipende dal fatto che qualche sottolivello sia riempito per metà o completamente di elettroni. E se è così, allora dobbiamo cercare la violazione successiva nell’atomo nel cui guscio elettronico “arriva” per ultimo il nono D-elettrone. Infatti, l'atomo di rame ne ha 3 D-il sottolivello ha 10 elettroni e 4 S-c'è solo un sottolivello. Una diminuzione dell'energia degli orbitali di un sottolivello completamente o parzialmente riempito è la causa di una serie di importanti fenomeni chimici.
Compito n. 1. Metodi per esprimere la concentrazione delle soluzioni.
Condizioni per completare l'attività:
Compito n. 1 . Rispondi alla domanda posta.
Metodi per esprimere la concentrazione delle soluzioni
1. Concentrazione percentuale: il numero di g di una sostanza presente in 100 g di soluzione.
Soluzione al 5% C 6 H 12 O 6
Soluzione da 100 g – 5 g C 6 H 12 O 6, ovvero
5 g C 6 H 12 O 6 +95 g H 2 O
La concentrazione percentuale è correlata alle unità di massa.
2. Concentrazione molare - il numero di moli presenti in 1 litro di soluzione:
5mHCl NaCl=23+35,5=58,5
3. Concentrazione normale o equivalente: il numero di g equivalenti contenuti in 1 litro di soluzione
Equivalente acido = ;
E(HCl) = , E(H2SO4)= ,
Base equivalente = ![]() ;
;
E(NaOH) = , E(Al(OH)3)= ,
Equivalente di sale = ![]() ;
;
E(NaCl) = , E(Na2CO3) = ,
E(Al2(SO4)3) = ;
Equivalente di ossido = ![]()
2n Al 2 (SO 4) 3, equivalente a Al 2 (SO 4) 3 =
Ad esempio, in 1 litro della soluzione 2
Compito n. 2. Fornisci esempi dei seguenti tipi di reazioni chimiche: reazioni di decomposizione; reazioni di scambio
Compito n. 2. Reazioni di decomposizione:
AgNO3 +NaCl=AgCl +NaNO3
CaCO3 =CaO+CO2
Compito per il candidato n. 23
Compito n. 1. Teoria della dissociazione elettrolitica.
Compito n. 2. Comporre equazioni molecolari, ioniche complete e ioniche abbreviate per le reazioni dei seguenti sali: a) cloruro di cromo (III) e nitrato d'argento; b) cloruro di bario e solfato di manganese; c) nitrato di ferro (III) e idrossido di potassio.
Compito n. 1 . Rispondi alla domanda posta.
Gli elettroliti hanno diverse capacità di dissociazione.
Il grado di dissociazione (a) è il rapporto tra il numero di molecole disintegrate in ioni (n) e il numero totale di molecole di elettrolita disciolte (n 0):
Il grado di dissociazione è espresso come frazione decimale o, più spesso, come percentuale:
Se a = 1, o 100%, l'elettrolita si dissocia completamente in ioni.
Se a = 0,5, ovvero 50%, allora su 100 molecole di un dato elettrolita, 50 sono in uno stato di dissociazione.
A seconda di ci sono:
Elettroliti forti, la loro a in 0,1 n. soluzione superiore al 30%.
Si dissociano quasi completamente.
Relazionare:
– quasi tutti i sali;
– molti acidi minerali: H 2 SO 4, HNO 3, HCl, HClO 4, HBr, HJ, HMnO 4, ecc.
– basi di metalli alcalini e alcuni metalli alcalino terrosi: Ba(OH) 2 e Ca(OH) 2.
Elettroliti medi, la loro percentuale varia dal 3 al 30%. Questi includono acidi H 3 PO 4, H 2 SO 3, HF, ecc.
Elettroliti deboli nelle soluzioni acquose sono solo parzialmente dissociati, il loro contenuto è inferiore al 3%.
Relazionare:
– alcuni acidi minerali: H 2 CO 3, H 2 S, H 2 SiO 3, HCN;
– quasi tutti gli acidi organici;
– molte basi metalliche (eccetto le basi dei metalli alcalini e alcalino terrosi), nonché l'idrossido di ammonio;
– alcuni sali: HgCl 2, Hg(CN) 2.
Fattori che influenzanoUN
Natura del solvente:
Maggiore è la costante dielettrica del solvente, maggiore è il grado di dissociazione dell'elettrolita in esso contenuto.
Concentrazione della soluzione:
Il grado di dissociazione dell'elettrolita aumenta man mano che la soluzione viene diluita.
All'aumentare della concentrazione della soluzione, il grado di dissociazione diminuisce (frequenti collisioni di ioni).
Natura dell'elettrolita:
La dissociazione degli elettroliti dipende dal grado di dissociazione.
Temperatura:
Per gli elettroliti forti, a diminuisce con l'aumentare della temperatura, perché aumenta il numero di collisioni tra ioni.
Per gli elettroliti deboli, all'aumentare della temperatura, la a aumenta, e dopo i 60°C comincia a diminuire.
Costante di dissociazione elettrolitica
Nelle soluzioni di elettroliti deboli, dopo la dissociazione, si stabilisce un equilibrio dinamico tra molecole e ioni:
CH 3 COOH + H 2 O « CH 3 COO - + H 3 O +
. [H 3 O + ] / =K diss
Compito n. 2.Comporre equazioni molecolari, ioniche complete e ioniche abbreviate per le reazioni dei sali elencati.
a) CrCl3 + 3AgNO3 → Cr(NO3)3 + 3AgCl↓
Cr 3+ + 3Cl - + 3Ag + + 3NO 3 → Cr 3+ + 3NO 3 + 3AgCl↓
Cl - + Ag + → AgCl↓
b) BaCl2 + MnSO4 → BaSO4 ↓ + MnCl2
Ba 2+ + 2Cl - + Mn 2+ + SO 4 2- → BaSO 4 ↓ + Mn 2+ + 2Cl -
Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓
c) Fe(NO 3) 3 + 3KOH → Fe(OH) 3 ↓ + 3KNO 3
Fe 3+ + 3NO 3 - + 3K + + 3OH - → Fe(OH) 3 ↓ + 3K + + 3NO 3 -
Fe3+ + 3OH - → Fe(OH)3 ↓
Compito n. 1. Idrolisi dei sali.
Compito n. 1 . Rispondi alla domanda posta.
L'idrolisi del sale è la reazione di scambio del sale con l'acqua, con conseguente formazione di elettroliti deboli.
L'acqua, essendo un elettrolita debole, si dissocia negli ioni H + e OH -:
H2O<->OH-+H+
Quando alcuni sali vengono sciolti in acqua, gli ioni del sale disciolto interagiscono con gli ioni H+ e OH- dell'acqua.
C'è uno spostamento nell'equilibrio della dissociazione dell'acqua:
uno degli ioni acqua (o entrambi) si lega con gli ioni soluto per formarsi leggermente dissociato, O scarsamente solubile, Prodotto.
Ogni sale può essere pensato come formato da una base e da un acido.
Gli acidi e le basi sono elettroliti forti e deboli,
Secondo questo criterio i sali possono essere suddivisi in quattro tipologie:
sali formati da un catione basico forte e un anione acido forte;
2) sali formati da un catione basico forte e un anione acido debole;
3) sali formati da un catione base debole e un anione acido forte;
4) sali formati da un catione di una base debole e un anione di un acido debole.
I sali formati da un catione basico forte e da un anione acido forte non subiscono idrolisi.
Tali sali si dissociano completamente in ioni metallici e un residuo acido.
Per esempio:
Il sale NaCl è formato dalla base forte NaOH e dall'acido forte HCl e si dissocia completamente in ioni.
Sali formati da un catione basico forte e un anione acido debole
L'idrolisi di questo sale consiste nell'aggiunta di ioni idrogeno da una molecola d'acqua da parte degli ioni del residuo acido e nel rilascio di ioni idrossido, che provocano una reazione alcalina del mezzo,
Na2S<->2Na + + S 2-
NON<->OH-+H+
S2-+HOH<->SA - + OH -
Na2S + HOH = NaOH + NaHS
Sali formati da un catione base debole e un anione acido forte
L'idrolisi di questo sale comporta l'aggiunta di ioni metallici o ioni ammonio agli ioni idrossido di una molecola d'acqua e il rilascio di ioni idrogeno, che provocano una reazione acida nel mezzo,
ZnCl2<->Zn2+ + 2Cl -
HON =OH-+H+
Zn2++HOH<->ZnOH + + H +
ZnCl2+HOH<->HCl + ZnOHCl
Sali formati da un catione base debole e un anione acido debole
L'idrolisi di questo sale comporta l'aggiunta di ioni idrossido da parte di ioni metallici o ioni ammonio e di ioni idrogeno da una molecola d'acqua da parte di ioni acidi. La reazione dell'ambiente sarà neutrale.
CH 3 COONH 4<->CH3COO-+NH4+
HOH = H + + OH -
CH3COOHNH4OH
CH3COO + NH4+ + HOH<->CH3COOH + NH4OH
Compito n. 2. Caratterizza la posizione degli elementi n. 21, 32, 38 nella tavola periodica di D.I. Mendeleev. Scrivi le loro formule elettroniche e le strutture atomiche.
COSÌ 4
Scopo: ottenere un complesso solfato di rame-tetroammino sale da solfato di rame CuSO 4 ∙5H 2 O e una soluzione concentrata di ammoniaca NH 4 OH.
Misure di sicurezza:
1. I contenitori chimici in vetro richiedono un'attenta manipolazione; prima di iniziare il lavoro, è necessario controllarli per eventuali crepe.
2.Prima di iniziare il lavoro, è necessario verificare la funzionalità degli apparecchi elettrici.
3. Riscaldare solo in contenitori resistenti al calore.
4. Utilizzare i prodotti chimici con attenzione e con parsimonia. reagenti. Non assaggiarli, non annusarli.
5. Il lavoro deve essere svolto in vestaglia.
6. L'ammoniaca è velenosa e i suoi vapori irritano la mucosa.
Reagenti e attrezzature:
Soluzione concentrata di ammoniaca - NH 4 OH
Alcool etilico – C 2 H 5 OH
Solfato di rame - CuSO 4 ∙ 5H 2 O
Acqua distillata
Cilindri graduati
Piastre di Petri
Pompa per vuoto (pompa per vuoto a getto d'acqua)
Imbuti di vetro
Background teorico:
I composti complessi sono sostanze contenenti un agente complessante al quale è associato un certo numero di ioni o molecole chiamate addendi o legende. L'agente complessante con addendi costituisce la sfera interna del composto complesso. Nella sfera esterna dei composti complessi c'è uno ione legato allo ione complesso.
I composti complessi si ottengono dall'interazione di sostanze di composizione più semplice. Nelle soluzioni acquose si dissociano per formare uno ione complesso con carica positiva o negativa e il corrispondente anione o catione.
SO4 = 2+ + SO4 2-
2+ = Cu2+ + 4NH3 –
Il complesso 2+ colora la soluzione blu fiordaliso, ma Cu2+ e 4NH3 presi separatamente non danno tale colore. I composti complessi sono di grande importanza nella chimica applicata.
SO4 - cristalli viola scuro, solubili in acqua, ma non solubili in alcool. Se riscaldato a 1200°C perde acqua e parte dell'ammoniaca, mentre a 2600°C perde tutta l'ammoniaca. Se conservato all'aria, il sale si decompone.
Equazione di sintesi:
CuSO4 ∙ 5H2O +4NH4OH = SO4 ∙ H2O +8H2O
CuSO4 ∙ 5H2O + 4NH4OH= SO4 ∙ H2O +8H2O
Mm CuSO4∙5H2O = 250 g/mol
mm SO4 ∙ H2O = 246 g/mol
6g CuSO4∙5H2O - Xg
250 g CuSO4∙5H2O - 246 SO4∙H2O
Х=246∙6/250= 5,9 g SO4 ∙ H2O
Progresso:
Sciogliere 6 g di solfato di rame in 10 ml di acqua distillata in un vetro resistente al calore. Riscalda la soluzione. Mescolare vigorosamente fino a completa dissoluzione, quindi aggiungere la soluzione concentrata di ammoniaca in piccole porzioni finché non appare una soluzione salina complessa viola.
Quindi trasferire la soluzione in una capsula Petri o in una capsula di porcellana e far precipitare i cristalli del sale complesso con alcool etilico, che viene versato con una buretta per 30-40 minuti, il volume dell'alcol etilico è 5-8 ml.
Filtrare i cristalli di sale complesso risultanti su un imbuto Buchner e lasciarli asciugare fino al giorno successivo. Quindi pesare i cristalli e calcolare la resa percentuale.
5,9 g SO4 ∙ H2O - 100%
m di campione – X
X = m campione ∙100% / 5,9 g
Domande di controllo:
1.Che tipo di legami chimici ci sono nei sali complessi?
2.Qual è il meccanismo di formazione di uno ione complesso?
3.Come determinare la carica di un agente complessante e di uno ione complesso?
4.Come si dissocia un sale complesso?
5. Formule per la preparazione dei composti complessi diciano-sodio argentato.
Lavoro di laboratorio n. 6
Preparazione dell'acido ortoborico
Bersaglio: ottenere l'acido ortoborico dal borace e dall'acido cloridrico.
Misure di sicurezza:
1. I contenitori chimici in vetro richiedono un'attenta manipolazione e devono essere controllati per eventuali crepe prima dell'uso.
2. Prima di iniziare il lavoro, è necessario verificare la funzionalità degli apparecchi elettrici.
3. Riscaldare solo in contenitori resistenti al calore.
4. Utilizzare i prodotti chimici con attenzione e con parsimonia. Non assaggiarli, non annusarli.
5. Il lavoro dovrebbe essere svolto in vestaglia.
Attrezzature e reagenti:
Tetraborato di sodio (decaidrato) – Na 2 B 4 O 7 *10H 2 O
Acido cloridrico (conc.) – HCl
Acqua distillata
Fornello elettrico, pompa per vuoto (pompa per vuoto a getto d'acqua), bicchieri, carta da filtro, tazze di porcellana, bacchette di vetro, imbuti di vetro.
Progresso:
Sciogliere 5 g di sodio tetraborato decaidrato in 12,5 ml di acqua bollente, aggiungere 6 ml di soluzione di acido cloridrico e lasciare riposare per 24 ore.
Na2B4O7 *10H2O + 2HCl + 5H2O = 4H3 BO3 + 2NaCl
Il precipitato di acido ortoborico risultante viene decantato, lavato con poca acqua, filtrato sotto vuoto ed essiccato tra fogli di carta da filtro a 50-60°C in stufa.
Per ottenere cristalli più puri, l'acido ortoborico viene ricristallizzato. Calcolare i risultati teorici e pratici
Domande di controllo:
1. Formula strutturale di borace, acido borico.
2. Dissociazione di borace, acido borico.
3. Creare una formula per l'acido tetraborato di sodio.
Lavoro di laboratorio n. 7
Preparazione dell'ossido di rame(II).
Bersaglio: ottenere l'ossido di rame (II) CuO dal solfato di rame.
Reagenti:
Solfato di rame (II) CuSO 4 2- * 5H 2 O.
Idrossido di potassio e sodio.
Soluzione di ammoniaca (p=0,91 g/cm3)
Acqua distillata
Attrezzatura: bilance tecnochimiche, filtri, bicchieri, cilindri, pompe per vuoto(pompa per vuoto a getto d'acqua) , termometri, fornello elettrico, imbuto Buchner, beuta Bunsen.
Parte teorica:
L'ossido di rame (II) CuO è una polvere marrone-nero, a 1026 0 C si decompone in Cu 2 O e O 2, quasi insolubile in acqua, solubile in ammoniaca. L'ossido di rame (II) CuO si presenta naturalmente come un prodotto nero e terroso degli agenti atmosferici dei minerali di rame (melaconite). Nella lava del Vesuvio è stata ritrovata cristallizzata sotto forma di compresse tricline nere (tenorite).
Artificialmente, l'ossido di rame si ottiene riscaldando il rame sotto forma di trucioli o fili all'aria, a una temperatura rovente (200-375 0 C) o calcinando il nitrato di carbonato. L'ossido di rame così ottenuto è amorfo e ha una spiccata capacità di adsorbire i gas. Quando calcinato, a una temperatura più elevata, sulla superficie del rame si forma una scaglia a due strati: lo strato superficiale è ossido di rame (II) e lo strato interno è ossido di rame rosso (I) Cu 2 O.
L'ossido di rame viene utilizzato nella produzione di smalti per vetro per conferire un colore verde o blu, inoltre, il CuO viene utilizzato nella produzione del vetro rame-rubino; Quando riscaldato con sostanze organiche, l'ossido di rame le ossida, convertendo il carbonio e l'anidride carbonica e l'idrogeno in ossido e riducendosi in rame metallico. Questa reazione viene utilizzata nell'analisi elementare delle sostanze organiche per determinare il contenuto di carbonio e idrogeno in esse. Viene utilizzato anche in medicina, principalmente sotto forma di unguenti.
2. Preparare una soluzione satura dalla quantità calcolata di solfato di rame a 40 0 C.
3. Preparare una soluzione alcalina al 6% dalla quantità calcolata.
4. Riscaldare la soluzione alcalina a 80-90 0 C e versarvi la soluzione di solfato di rame.
5. La miscela viene riscaldata a 90 0 C per 10-15 minuti.
6. Il precipitato che si forma viene lasciato sedimentare e lavato con acqua fino alla rimozione dello ione. SO 4 2- (campione BaCl 2 + HCl).
Il rame appartiene al gruppo dei sette metalli conosciuti dall'uomo fin dall'antichità. Oggi, non solo il rame, ma anche i suoi composti sono ampiamente utilizzati in vari settori, agricoltura, vita quotidiana e medicina.
Il sale di rame più importante è il solfato di rame. La formula di questa sostanza è CuSO4. È un elettrolita forte e costituito da piccoli cristalli bianchi, altamente solubili in acqua, senza sapore né odore. La sostanza non è infiammabile ed è ignifuga; durante l'uso è completamente esclusa la possibilità di combustione spontanea. Il solfato di rame, se esposto anche alla più piccola quantità di umidità dell'aria, acquisisce un caratteristico colore blu con blu brillante. In questo caso, il solfato di rame viene convertito in pentaidrato blu CuSO4 · 5H2O, noto come solfato di rame.
Nell'industria, il solfato di rame può essere ottenuto in diversi modi. Uno di questi, il più comune, è la dissoluzione dei rifiuti di rame nel solfato di rame diluito. In laboratorio, il solfato di rame si ottiene mediante una reazione di neutralizzazione con acido solforico. La formula del processo è la seguente: Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O.
La proprietà di cambiare colore del solfato di rame viene utilizzata per rilevare la presenza di umidità nei liquidi organici. Viene utilizzato per disidratare l'etanolo e altre sostanze in condizioni di laboratorio.
Il solfato di rame o solfato di rame è ampiamente utilizzato in agricoltura. Il suo utilizzo consiste innanzitutto nell'utilizzare una soluzione debole per irrorare le piante e trattare i cereali prima della semina al fine di distruggere le spore fungine dannose. A base di solfato di rame, vengono prodotti la famosa poltiglia bordolese e il latte di calce, venduti attraverso punti vendita e destinati a curare le piante dalle malattie fungine e a distruggere gli afidi dell'uva.
Il solfato di rame è spesso utilizzato nelle costruzioni. Il suo utilizzo in questo ambito è quello di neutralizzare le perdite ed eliminare le macchie di ruggine. La sostanza viene utilizzata anche per rimuovere i sali da superfici in mattoni, cemento o intonacate. Inoltre, viene utilizzato per trattare il legno come antisettico per evitare processi di decomposizione.
Nella medicina ufficiale, il solfato di rame è un medicinale. È prescritto dai medici per uso esterno come colliri, soluzioni per risciacqui e lavande, e anche per il trattamento delle ustioni causate dal fosforo. Come rimedio interno, viene utilizzato per irritare lo stomaco per indurre il vomito se necessario.
Inoltre, le vernici minerali sono costituite da solfato di rame; viene utilizzato nelle soluzioni di filatura per la produzione
Nell'industria alimentare, il solfato di rame è registrato come additivo alimentare E519, utilizzato come fissativo del colore e conservante.
Quando il solfato di rame viene venduto nei negozi al dettaglio, viene etichettato come sostanza altamente pericolosa. Se entra nel sistema digestivo umano in una quantità compresa tra 8 e 30 grammi, può essere fatale. Pertanto, quando usi il solfato di rame nella vita di tutti i giorni, dovresti stare molto attento. Se la sostanza viene a contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare accuratamente la zona con acqua corrente fredda. Se entra nello stomaco, è necessario fare un risciacquo debole, bere un lassativo salino e un diuretico.
Quando si lavora con il solfato di rame a casa, utilizzare guanti di gomma e altri dispositivi di protezione, compreso un respiratore. È vietato utilizzare contenitori per alimenti per la preparazione di soluzioni. Dopo aver terminato il lavoro, assicurati di lavarti le mani e il viso e di sciacquarti la bocca.
Concetti generali sull'idrolisi del solfato di rame (II).
DEFINIZIONE
Solfato di rame(II).- sale medio. Assorbe l'umidità. Il solfato di rame anidro (II) è costituito da cristalli incolori e opachi.
Se è presente acqua (il nome banale è solfato di rame), i cristalli sono blu. FormulaCuSO4.
Riso. 1. Solfato di rame (II). Aspetto.
Idrolisi del solfato di rame(II).
Il solfato di rame (II) è un sale formato da un acido forte - solforico (H 2 SO 4) e una base debole - idrossido di rame (II) (Cu (OH) 2). Idrolizza al catione. La natura dell'ambiente è acida. Teoricamente, una seconda fase è possibile.
Primo stadio:
CuSO4 ↔ Cu2+ + SO42- ;
Cu2+ + SO4 2- + HOH ↔ CuOH + + SO4 2- + H + ;
CuSO4 + HOH ↔ 2SO4 + H2SO4.
Seconda fase:
2SO4 ↔ 2CuOH + +SO42- ;
CuOH + + SO 4 2 + HOH ↔ Cu(OH) 2 + SO 4 2 + HOH.
2SO4 + HOH ↔Cu(OH)2 + H2SO4.
Esempi di risoluzione dei problemi
ESEMPIO 1
| Esercizio | La limatura di ferro (3,1 g) è stata aggiunta ad una soluzione di solfato di rame (II) del peso di 25 g. Determina quale massa di rame si è formata durante la reazione. |
| Soluzione | Scriviamo l'equazione di reazione: CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu↓. Calcoliamo le quantità di sostanze che hanno reagito. Masse molari, che sono rispettivamente 160 e 56 g/mol per il rame (II) e il solfato di ferro: υ(CuSO4) = m (CuSO4)/M(CuSO4) = 25/160 = 0,16 mol. υ(Fe)= m(Fe)/M(Fe) = 3,1/56 = 0,05 mol. Confrontiamo i valori ottenuti: υ(CuSO4)>υ(Fe). Effettuiamo calcoli in base alla sostanza che scarseggia. Questo è ferro. Secondo l'equazione di reazione υ(Fe)=υ(Cu)= 0,05 mol. Quindi la massa del rame sarà uguale (massa molare - 64 g/mol): m(Cu)= υ(Cu)× M(Cu)= 0,05×64 =3,2 g. |
| Risposta | La massa del rame è 3,2 g. |
ESEMPIO 2
| Esercizio | Quale sarà la concentrazione della soluzione di solfato di rame (II) se altri 10 g della stessa sostanza vengono aggiunti a 180 g di una soluzione al 30% di questo sale? |
| Soluzione | Troviamo la massa del solfato di rame (II) disciolto in una soluzione al 30%: ω=m soluto/m soluzione ×100%. m soluto (CuSO 4) = ω/100% × m soluzione (CuSO 4) = 30/100 × 180 = 54 g. Troviamo la massa totale di solfato di rame (II) disciolto nella nuova soluzione: somma di m soluto (CuSO 4) = m soluto (CuSO 4) + m (CuSO 4) = 54 + 10 = 64 g. Calcoliamo la massa della nuova soluzione: somma della soluzione m (CuSO 4) = soluzione m (CuSO 4) + m (CuSO 4) = 180+10 = 190 g. Determiniamo la concentrazione di massa della nuova soluzione: ω=m somma soluto (CuSO 4) / m soluzione (CuSO 4) somma ×100% = 64/190 ×100% =33,68%. |
| Risposta | Concentrazione della soluzione 33,68% |