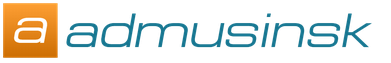La cavità orale comprende il vestibolo e la bocca stessa. Il vestibolo è formato dalle labbra, dal lato esterno delle guance, dai denti e dalle gengive. Le labbra sono ricoperte all'esterno da un sottile strato di epitelio, all'interno sono rivestite da mucosa, che è una continuazione dentro guance Coprono strettamente i denti e sono attaccati alle gengive mediante il frenulo superiore e inferiore.
La bocca è formata da:
- mucosa buccale;
- incisivi, canini, molari grandi e piccoli;
- gengive;
- lingua;
- palato molle e duro.

Riso. 1. Struttura della cavità orale.
Maggiori dettagli sull'edificio cavità orale presentato in tabella.
|
Cavità orale |
Struttura |
Funzioni |
|
Il lato esterno è ricoperto da epitelio cutaneo, il lato interno è ricoperto da mucosa. Lo strato intermedio è costituito da fibre muscolari penetrate da vasi e nervi |
Aprono e chiudono l'apertura della bocca, partecipano alla formazione del bolo alimentare |
|
|
Organo muscolare (muscolo striato) penetrato da fibre nervose e vasi sanguigni. La parte superiore è ricoperta da una membrana mucosa, sulla cui superficie sono presenti papille sensibili contenenti recettori. Trattenuto nella cavità orale dal frenulo |
Valuta la qualità ed i parametri fisici degli alimenti, forma e favorisce il bolo alimentare |
|
|
Osso duro ricoperto di mucosa, piega morbida e mucosa che si trova dietro il palato duro |
Aiuta a formare un bolo di cibo e a spostarlo verso la faringe |
|
|
Sono costituiti da dentina ricoperta di smalto. All'interno della dentina è presente una cavità piena di polpa sciolta tessuto connettivo. I canali si estendono dalla cavità attraverso la quale i vasi sanguigni e le fibre nervose entrano nel dente. |
Macinazione meccanica degli alimenti. Gli incisivi e i canini catturano e trattengono il cibo, i molari macinano |
|
|
Processi delle mascelle ricoperti di mucosa |
Tiene denti e labbra |

Riso. 2. Struttura interna dente
Funzioni
Le principali funzioni della cavità orale nel processo di digestione:
TOP 1 articoloche stanno leggendo insieme a questo
- riconoscimento del gusto;
- macinazione di alimenti solidi;
- impartire la temperatura corporea ai prodotti in entrata;
- formazione di un bolo alimentare;
- scomposizione degli zuccheri;
- protezione contro la penetrazione di microrganismi patogeni.
La funzione principale della digestione nella cavità orale umana è eseguita dalla saliva. Le ghiandole salivari, situate nella mucosa, inumidiscono il cibo con l'aiuto della saliva secreta e della lingua, formando un bolo alimentare.
Ci sono tre paia di ghiandole grandi:
- parotide;
- sottomandibolare;
- sublinguale.

Riso. 3. Posizione delle ghiandole salivari.
La saliva è composta per il 99% da acqua. La restante percentuale è costituita da sostanze biologicamente attive che presentano proprietà diverse.
La saliva contiene:
- lisozima - enzima antibatterico;
- mucina - una sostanza proteica viscosa che lega le particelle di cibo in un unico grumo;
- amilasi e maltasi - enzimi che scompongono l'amido e altri zuccheri complessi.
Gli enzimi sono composti proteici che accelerano le reazioni chimiche. Sono un catalizzatore nella scomposizione del cibo.
In piccole quantità, la saliva contiene altri catalizzatori enzimatici, nonché sali organici e oligoelementi.
Digestione
Una breve descrizione di come avviene la digestione nella cavità orale è la seguente:
- il pezzo di cibo entra nella cavità attraverso gli incisivi;
- a causa dei muscoli masticatori che trattengono la mascella, inizia il processo di masticazione;
- i molari macinano il cibo, che è abbondantemente inumidito con la saliva;
- le guance, la lingua e il palato duro arrotolano un bolo alimentare;
- Il palato molle e la lingua spingono il cibo preparato nella faringe.
Il cibo che entra nella cavità orale irrita i recettori per vari scopi (temperatura, tattili, olfattivi), che rispondono producendo saliva, succo gastrico e bile.
Cosa abbiamo imparato?
La cavità orale ha Grande importanza durante il processo di digestione. Attraverso le guance, i denti e la lingua, il cibo in entrata viene frantumato e spostato nella faringe. Il cibo inumidito con la saliva si ammorbidisce e si attacca formando un unico bolo alimentare. Gli enzimi presenti nella saliva iniziano la digestione scomponendo l'amido e altri zuccheri.
Prova sull'argomento
Valutazione del rapporto
Voto medio: 4 . Valutazioni totali ricevute: 440.
1. Elencare i dipartimenti apparato digerente.
Sezioni dell'apparato digerente: cavità orale, faringe, esofago, stomaco, intestino tenue e crasso, ano e una serie di grandi ghiandole digestive: fegato, pancreas, ghiandole salivari.
2. Quali sostanze iniziano a degradarsi nella cavità orale? In quale ambiente chimico sono attivi gli enzimi delle ghiandole salivari? Dai un nome al prodotto finale di questa decomposizione nella cavità orale.
La saliva ha una reazione leggermente alcalina (pH = 6,5-7,5) ed è composta per il 98-99% da acqua e per l'1-2% da muco, sostanze organiche e inorganiche ed enzimi digestivi. Enzimi salivari: amilasi e maltasi (iniziano la scomposizione dei carboidrati nella cavità orale) e lipasi (iniziano la scomposizione dei grassi). La completa decomposizione delle sostanze nella cavità orale non avviene a causa della breve durata del cibo nella cavità orale. Con un'esposizione più lunga agli enzimi, l'amido viene scomposto in maltosio e il maltosio in glucosio.
3. Raccontaci la struttura del dente.
Un dente è costituito da una radice nascosta nella cellula ossea della mascella e da una parte visibile: la corona e il collo. All'interno della radice c'è un canale che si espande nella cavità del dente ed è pieno di polpa contenente vasi sanguigni e nervi. Il dente è costituito da una sostanza densa simile all'osso - dentina, ricoperta di cemento nella zona della radice, e smalto molto denso nella zona della corona, che protegge il dente dall'abrasione e dalla penetrazione dei batteri.
4. A che età i denti da latte diventano permanenti?
Dentizione Denti permanenti, ad eccezione dei denti del giudizio, inizia a 6-7 anni e termina a 10-12 anni; L'eruzione dei denti del giudizio a volte può terminare entro i 20-30 anni, raramente più tardi.
5. Quanti denti ha una persona? Scopri cos'è una formula dentale e come viene scritta. Usando il disegno, trucca formula dentale persona.
In totale, una persona ha 32 denti: su ciascuna mascella ci sono 4 incisivi, 2 canini, 4 piccoli molari (premolari) e 6 grandi molari (molari).
Formula dentale - scritta sotto forma di notazioni speciali breve descrizione sistema dentale dei mammiferi e di altri tetrapodi eterodonti. Tutti i denti sono divisi in 4 settori (in senso antiorario). I denti sono numerati da 1 a 8. Poiché esistono solo 32 formazioni ossee, ciascun numero verrà utilizzato per designare i quattro denti con lo stesso nome nella mascella superiore e inferiore. Per fare ciò, entrambe le file dentali sono convenzionalmente divise a metà lungo la linea tra gli incisivi centrali, in modo che su ciascun lato di questa linea ci siano: incisivo centrale - 1; incisivo laterale – 2; zanna – 3; primo premolare – 4; secondo premolare – 5; primo molare – 6; secondo molare – 7; terzo molare – 8.
6. Familiare a molti di noi mal di denti. Cosa fa esattamente male al dente? Cosa provoca la carie? Perchè è pericoloso?
Il mal di denti si verifica a causa dell'irritazione dei recettori sensibili nella polpa dentale. Maggior parte causa comune il mal di denti è carie. I denti sporchi si ricoprono di detriti alimentari, batteri e componenti della saliva. Questo muco è chiamato placca. I batteri, nutrendosi degli zuccheri presenti nei residui alimentari, rilasciano acido, che distrugge prima lo smalto e poi la dentina. Di conseguenza, si forma una cavità nel dente e forte dolore. Se il processo carioso non viene interrotto, il danno interesserà sia il canale del dente che anche tessuto osseo mascella, che può portare alla necessità di rimuovere un dente cariato. Se la carie appare sui denti da latte, i batteri possono penetrare nelle gemme dei denti permanenti e quindi anche loro si infetteranno.
7. Cos'è la saliva? Che funzione svolge?
La saliva è la secrezione delle ghiandole salivari, secreta nella cavità orale e costituita da acqua, muco, sostanze organiche e inorganiche ed enzimi digestivi. Funzioni della saliva: la saliva bagna il cibo durante la masticazione, facilitando la formazione di un bolo per la deglutizione del cibo; Gli enzimi digestivi iniziano a scomporre carboidrati e grassi; il lisozima contenuto nella saliva ha un effetto disinfettante, distruggendo le membrane delle cellule batteriche.
8. Che ruolo gioca la lingua?
Durante la masticazione dirige il cibo verso i denti, lo mescola e lo sposta nella faringe per la deglutizione. Anche la lingua è un organo del gusto ed è coinvolta nella formazione dei suoni del parlato.
9. Qual è il meccanismo di movimento di un bolo di cibo lungo l'esofago?
Masticato, inumidito con saliva, un pezzo di cibo scivoloso entra nella faringe e poi nell'esofago. Il cibo viene spinto attraverso l'esofago grazie alla peristalsi, ovvero le contrazioni ondulatorie delle sue pareti. In questo caso, i muscoli situati nella parete dell'esofago si contraggono, spingendo il bolo di cibo nello stomaco. Questo processo richiede 6–8 secondi.
La faringe è il punto in cui l'aria e il cibo entrano nel corpo. Ciò crea potenzialmente il pericolo che grumi di cibo possano entrare nel sistema respiratorio: laringe, rinofaringe. Tuttavia, ciò non accade, poiché durante la deglutizione del cibo la cartilagine - l'epiglottide chiude l'ingresso della laringe e l'ugola del palato molle si solleva e separa il rinofaringe dall'orofaringe. Questi processi avvengono in modo riflessivo. Se si parla mentre si mangia, l'epiglottide può assumere una posizione intermedia, che può far entrare il bolo alimentare Vie aeree.
11. Perché è così importante masticare bene il cibo?
Quanto più accuratamente il cibo viene frantumato in bocca, tanto meglio è preparato per la lavorazione da parte degli enzimi e, quindi, più attivamente e rapidamente si scompone nei suoi componenti. E viceversa, più grandi sono i pezzi di cibo che entrano nello stomaco, più tempo impiega i succhi digestivi per assorbirli ed elaborarli. E il lavoro eccessivo delle ghiandole dell'apparato digerente provoca l'interruzione della loro funzione, il che comporta varie malattie organi digestivi, ad esempio gastrite. Inoltre, un’eccessiva pienezza dello stomaco mette sotto pressione il diaframma e interrompe il funzionamento del cuore.
I pezzi grandi non masticati entrano prima nell'esofago. Possono facilmente ferirlo.
Una persona che mangia velocemente si sazia più lentamente. Ciò è dovuto al fatto che durante la masticazione inizia a produrre istamina che, raggiungendo il cervello, gli dà un segnale di saturazione. Ciò avviene però solo venti minuti dopo l’inizio del pasto. Se una persona mangia lentamente, mangerà meno cibo durante quei venti minuti e si sentirà sazia con meno calorie.
Digerire il cibo è sufficiente processo difficile, che si riduce alla scomposizione di grandi molecole di proteine, grassi e carbonio in monomeri che vengono facilmente assorbiti dalle cellule del corpo. IN diversi dipartimenti tratto digerente si scompongono vari composti, che vengono poi assorbiti dalla mucosa dell'intestino tenue e distribuiti in tutto il corpo. La digestione inizia nella cavità orale.
Prima di considerare come avviene la digestione, è necessario familiarizzare almeno brevemente con la sua struttura.
Struttura della cavità orale
In anatomia è consuetudine dividerlo in due sezioni:
- Il vestibolo della bocca (lo spazio tra le labbra e i denti);
- La cavità orale stessa (limitata dai denti, dal palato osseo e dal diaframma della bocca);
Ogni elemento del cavo orale ha una propria funzione ed è responsabile di uno specifico processo di trasformazione degli alimenti.
I denti sono responsabili della lavorazione meccanica degli alimenti solidi. Con l'aiuto di zanne e incisivi, una persona morde il cibo, quindi lo schiaccia con quelli piccoli. La funzione dei grandi molari è macinare il cibo.
La lingua è un grande organo muscolare attaccato al pavimento della bocca. La lingua è coinvolta non solo nella lavorazione del cibo, ma anche nei processi linguistici. Muovendosi, questo organo muscolare mescola il cibo tritato con la saliva e forma un bolo alimentare. Inoltre, è nei tessuti della lingua che si trovano i recettori del gusto, della temperatura, del dolore e dei meccanismi.
Le ghiandole salivari sono parotidi, sublinguali ed escono nella cavità orale attraverso condotti. La loro funzione principale è la produzione e l'eliminazione della saliva, che è di grande importanza per i processi digestivi. Le funzioni della saliva sono le seguenti:
- Digestivo (la saliva contiene enzimi che aiutano ad abbattere i carboni);
- Protettivo (la saliva contiene lisozima, che ha forti proprietà battericide. Inoltre, la saliva contiene immunoglobuline e fattori di coagulazione del sangue. La saliva protegge la cavità orale dalla disidratazione);
- Escretore (sostanze come urea, sali, alcol e alcuni farmaci vengono rilasciati con la saliva);
La digestione nel cavo orale: fase meccanica
Gli alimenti più diversi possono entrare nella cavità orale e, a seconda della loro consistenza, passano immediatamente nell'esofago durante l'atto di deglutizione (bevande, alimenti liquidi) oppure subiscono una lavorazione meccanica che facilita ulteriori processi di digestione.
Come già accennato, il cibo viene frantumato con l'aiuto dei denti. I movimenti della lingua sono necessari per mescolare gli alimenti masticati con la saliva. Sotto l'influenza della saliva, il cibo si ammorbidisce e si ricopre di muco. La mucina, contenuta nella saliva, partecipa alla formazione del bolo alimentare, che successivamente passa nell'esofago.
La digestione nel cavo orale: fase enzimatica
Include anche alcuni enzimi coinvolti nella scomposizione dei polimeri. La decomposizione del carbonio avviene nella cavità orale, che continua già all'interno intestino tenue.
La saliva contiene un complesso di enzimi chiamato ptialina. Sotto la loro influenza, i polisaccaridi si decompongono in disaccaridi (principalmente maltosio). Successivamente, il maltosio, sotto l'influenza di un altro enzima, viene scomposto in glucosio monosaccaride.
Come cibo più lungo si trova nel cavo orale ed è suscettibile all'azione enzimatica, tanto più facilmente viene digerito in tutti gli altri distretti del tratto erboristico. Ecco perché i medici consigliano sempre di masticare il cibo il più a lungo possibile.
Qui finisce la digestione in bocca. Il bolo del cibo passa oltre e, cadendo sulla radice della lingua, innesca il processo riflessivo della deglutizione, in cui il cibo passa nell'esofago e successivamente entra nello stomaco.
In sintesi, nella cavità orale avvengono processi come la macinazione del cibo, l'analisi del suo sapore, la bagnatura con la saliva, la miscelazione e la scomposizione primaria dei carboidrati.
Il processo iniziale di trasformazione degli alimenti avviene nella cavità orale. Nella cavità orale avviene: macinazione del cibo; bagnandolo con la saliva; formazione di un bolo alimentare.
Il cibo rimane in bocca per 10-15 secondi, dopodiché viene spinto nella faringe e nell'esofago dalle contrazioni muscolari della lingua.
Il cibo che entra in bocca è irritante per il gusto, i recettori tattili e termici situati nella mucosa della lingua e sparsi in tutta la mucosa della cavità orale.
Gli impulsi provenienti dai recettori lungo le fibre centripete dei nervi trigemino, facciale e glossofaringeo entrano nei centri nervosi, che stimolano riflessivamente la secrezione delle ghiandole salivari, delle ghiandole dello stomaco e del pancreas e la secrezione biliare. Gli influssi efferenti modificano anche l'attività motoria dell'esofago, dello stomaco, dell'intestino tenue prossimale, influenzano l'afflusso di sangue agli organi digestivi e aumentano di riflesso il consumo energetico necessario per l'elaborazione e l'assimilazione del cibo.
Quelli. Nonostante la breve permanenza del cibo nella cavità orale (15-18 s), gli effetti scatenanti provengono dai suoi recettori su quasi tutto il tratto digestivo. L'irritazione dei recettori della lingua, della mucosa orale e dei denti è particolarmente importante nell'attuazione dei processi digestivi nella cavità orale stessa.
La masticazione è una delle fasi iniziali del processo di assorbimento del cibo, consistente nel macinare, macinare e mescolare il cibo con la saliva, cioè. nella formazione del bolo alimentare.
Per la dissoluzione è necessario bagnare e mescolare con la saliva, senza la quale è impossibile valutare il gusto del cibo e la sua idrolisi.
La masticazione avviene a causa delle contrazioni dei muscoli masticatori, che muovono la mascella inferiore rispetto a quella superiore. Anche i muscoli facciali e quelli della lingua prendono parte al processo.
Una persona ha 2 file di denti. Ciascuno ha incisivi (2), canini (2), molari piccoli (2) e grandi (3). Gli incisivi e i canini mordono il cibo, i piccoli molari lo schiacciano e i grandi molari lo macinano. Gli incisivi possono sviluppare una pressione sul cibo di 11-25 kg/cm2, i molari - 29-90. L'atto di masticare viene effettuato in modo riflessivo, ha natura a catena, componenti automatizzate e volontarie.
I nuclei motori del midollo allungato, il nucleo rosso, e materia nera, nuclei sottocorticali e corteccia cerebrale. L’insieme dei neuroni che controllano la masticazione è chiamato centro masticatorio. Gli impulsi da esso viaggiano attraverso le fibre motorie del nervo trigemino fino ai muscoli masticatori. Fanno movimenti mascella inferiore giù, su, avanti, indietro e lateralmente. I muscoli della lingua, delle guance e delle labbra muovono il bolo del cibo nella cavità orale, servono e trattengono il cibo tra le superfici masticatorie dei denti. Nella coordinazione della masticazione giocano un ruolo importante gli impulsi provenienti dai propriocettori dei muscoli masticatori e dai meccanorecettori del cavo orale e dei denti.
Lo studio del processo di masticazione è complesso: metodo cinematico, metodo elettromiografico. Il metodo grafico di registrazione si chiama: masticazionegrafia.
Il masticatorio è costituito da un palloncino di gomma posto in una speciale custodia di plastica, fissata alla mascella inferiore. Il pallone è collegato ad una capsula Marey, la cui penna registra i movimenti della mascella sul tamburo del chimografo. La masticografia distingue le seguenti fasi: riposo, introduzione del cibo in bocca, indicativa, principale, formazione di un bolo alimentare.
Ghiandole salivari.
La saliva è prodotta da tre paia di grandi ghiandole ( parotide, sottomandibolare e sublinguale) e molte piccole ghiandole della lingua, della mucosa del palato e delle guance . La saliva entra nella cavità orale attraverso i dotti escretori.
La saliva delle ghiandole ha una consistenza diversa: le ghiandole sottolinguali e sottomandibolari secernono una saliva più viscosa e densa rispetto alla ghiandola parotide. Questa differenza è determinata dalla presenza di una sostanza proteica – la mucina.
La secrezione mista (con mucina) viene isolata:
ghiandole sottomandibolari
ghiandole sublinguali
ghiandole nella mucosa della lingua e del palato.
Viene isolata la secrezione sierosa (saliva liquida con un'alta concentrazione di sodio, potassio e un'elevata attività di amilasi).
parotide
piccole ghiandole sulle superfici laterali della lingua.
La saliva mista ha un pH compreso tra 5,8 e 7,4 (la saliva delle ghiandole parotidi ha un pH<5,81). С увеличением скорости секреции рН слюны повышается до 7,8.
La mucina conferisce alla saliva un peculiare aspetto viscido e scivoloso, rendendo più facile la deglutizione del cibo imbevuto di saliva.
La saliva contiene diversi enzimi: α-amilasi, β-glucosidasi.
Gli enzimi salivari sono altamente attivi, ma la completa degradazione dei carboidrati non avviene a causa della breve durata del cibo in bocca. L'idrolisi dei carboidrati con l'aiuto di questi enzimi continua all'interno del bolo alimentare nello stomaco. Sulla superficie del bolo alimentare, l'ambiente acido (HCl0,01%) blocca l'azione degli enzimi.
Gli enzimi proteolitici della saliva sono importanti per l'igiene del cavo orale. Ad esempio, il lisozima è altamente battericida; Proteinasi - effetto disinfettante.
La quantità e la composizione della saliva sono adattate al tipo di cibo consumato, alla dieta e alla consistenza del cibo.
Più saliva viscosa viene secreta per le sostanze alimentari e maggiore è la quantità, più secco è il cibo. Per sostanze rifiutate e amarezza: una quantità significativa di saliva liquida.
La saliva secreta per la maggior parte delle sostanze alimentari contiene 4 volte più mucina della saliva secreta quando vengono introdotte in bocca le cosiddette sostanze di scarto (acido cloridrico, amari, ecc.).
Metodi per studiare la salivazione.
Nei cani: fistola del dotto escretore della ghiandola parotide o della ghiandola sottomandibolare con un pezzo di mucosa.
Nell'uomo: utilizzando una capsula - l'imbuto Lashley-Krasnogorsky, che viene applicato al dotto escretore della ghiandola salivare.
Regolazione della salivazione.
Al di fuori dell'assunzione di cibo, una persona secerne la saliva ad una velocità di 0,24 ml/min, durante la masticazione - 3-3,5 ml/min, con l'introduzione di acido citrico (0,5 mmol) - 7,4 ml/min.
Mangiare cibo stimola la salivazione sia condizionatamente che incondizionatamente come riflesso.
L'irritante dei riflessi salivari incondizionati è il cibo o le sostanze rifiutate che agiscono sui recettori della cavità orale.
Il tempo che intercorre tra l'esposizione (assunzione di cibo) a uno stimolo e l'inizio della salivazione è chiamato periodo di latenza. (1-30 secondi)
Gli impulsi dei recettori entrano nel centro salivare, situato nel midollo allungato (nella regione dei nuclei del nervo glossofaringeo). Quando questa zona è irritata si può ottenere un'abbondante secrezione di saliva con diversa composizione qualitativa.
Gli impulsi alle ghiandole salivari seguono le fibre nervose efferenti parasimpatiche e simpatiche.
Influenze parasimpatiche. Sotto l'influenza dell'acetilcolina rilasciata dalle terminazioni dei neuroni postgangliari, viene rilasciata una grande quantità di saliva liquida con un'alta concentrazione di elettroliti e una bassa mucina. Stimolano la salivazione e i chinini, che dilatano i vasi sanguigni delle ghiandole salivari.
Influenze simpatiche. La norepinefrina, secreta dalle terminazioni dei neuroni postgangliari, provoca il rilascio di una piccola quantità di saliva densa e favorisce la formazione di mucina ed enzimi nelle ghiandole.
La stimolazione simultanea dei nervi parasimpatici aumenta l'effetto secretorio. Le differenze nella secrezione in risposta ai diversi alimenti sono spiegate dai cambiamenti nelle frequenze degli impulsi lungo le fibre nervose parasimpatiche e simpatiche. Questi cambiamenti possono essere unidirezionali o multidirezionali.
Fattori che portano all'inibizione della salivazione: emozioni negative; disidratazione del corpo; irritazioni dolorose, ecc.
Diminuzione della secrezione delle ghiandole salivari - iposalivazione.
Salivazione eccessiva – ipersalivazione.
Deglutizione.
La masticazione termina con la deglutizione, il passaggio di un bolo di cibo dalla cavità orale allo stomaco.
Secondo la teoria di Magendie l'atto della deglutizione si divide in 3 fasi: volontaria orale; faringeo involontario (veloce); esofageo involontario – a lungo termine, lento.
1) Un bolo alimentare con un volume di 5-15 cm 3 viene separato in bocca dalla massa alimentare frantumata e inumidita. Questa protuberanza viene premuta contro il palato duro mediante movimenti volontari della parte anteriore e poi centrale della lingua e trasferita alla radice della lingua attraverso gli archi anteriori.
2) Non appena il bolo alimentare raggiunge la radice della lingua, l'atto di deglutizione entra in una fase involontaria veloce, che dura ~ 1 secondo. Questo atto è un riflesso complesso ed è regolato dal centro della deglutizione nel midollo allungato. Le informazioni al centro della deglutizione passano attraverso le fibre afferenti del nervo trigemino, dei nervi laringei e del nervo glossofaringeo. Da esso, gli impulsi lungo le fibre efferenti dei nervi trigemino, glossofaringeo, ipoglosso e vago vanno ai muscoli che assicurano la deglutizione. Se tratti la radice della lingua e della faringe con una soluzione di cocaina (spegni i recettori), la deglutizione non avverrà.
Il centro della deglutizione è situato nel midollo allungato, nella regione del fondo del quarto ventricolo, leggermente al di sopra del centro della respirazione. È associato al centro respiratorio, vasomotore e ai centri che regolano l'attività del cuore. Durante l'atto della deglutizione, la respirazione viene trattenuta e la frequenza cardiaca aumenta.
Si verifica una contrazione riflessa dei muscoli che sollevano il palato molle (che impedisce al cibo di entrare nella cavità nasale). Muovendo la lingua il bolo di cibo viene spinto nella faringe. Allo stesso tempo, si verifica una contrazione dei muscoli che sposta l'osso ioide e provoca il sollevamento della laringe, a seguito della quale l'ingresso delle vie respiratorie viene chiuso, impedendo l'ingresso di cibo al loro interno.
Il trasferimento del bolo alimentare nella faringe è facilitato da un aumento della pressione nella cavità orale e da una diminuzione della pressione nella faringe. La radice sollevata della lingua e gli archi ad essa strettamente adiacenti impediscono il movimento inverso del cibo nella cavità orale.
Dopo l'ingresso del bolo alimentare nella faringe, i muscoli si contraggono restringendo il lume sopra il bolo alimentare, in conseguenza del quale si sposta nell'esofago. Ciò è facilitato dalla differenza di pressione nelle cavità della faringe e dell'esofago. Prima della deglutizione, lo sfintere faringoesofageo è chiuso; durante la deglutizione la pressione nella faringe sale a 45 mm Hg; Art., lo sfintere si apre e il bolo alimentare entra all'inizio dell'esofago, dove la pressione non è superiore a 30 mm Hg. Arte.
Le prime due fasi dell'atto di deglutizione durano circa 1 s.
3) Movimento del cibo attraverso l'esofago.
Il movimento del bolo alimentare attraverso l'esofago avviene (immediatamente, immediatamente) dopo il movimento della deglutizione (automaticamente, di riflesso).
Il tempo di passaggio degli alimenti solidi è di 8-9 secondi.
Il tempo di passaggio per gli alimenti liquidi è di 1-2 secondi.
La contrazione dei muscoli esofagei ha la natura di un'onda, che si verifica nella parte superiore dell'esofago e poi lungo tutta la sua lunghezza (contrazioni peristaltiche). Allo stesso tempo, i muscoli ad anello dell'esofago si contraggono in sequenza, spostando il bolo alimentare. Un'onda di tono diminuito (rilassamento) si muove davanti a lui. La velocità del suo movimento è maggiore delle onde di contrazione e raggiunge lo stomaco in 1-2 s.
L'onda peristaltica primaria causata dalla deglutizione raggiunge lo stomaco. A livello dell'intersezione dell'esofago con l'arco aortico si verifica un'onda secondaria. L'onda secondaria spinge anche il bolo di cibo nella parte cardiaca dello stomaco. La velocità media della sua diffusione è di 2-5 cm/s, coprendo un tratto di esofago di 10-30 cm in 3-7 s.
La regolazione della motilità esofagea viene effettuata dalle fibre efferenti del vago e dei nervi simpatici; Il sistema nervoso intramurale gioca un ruolo importante.
Al di fuori dei movimenti di deglutizione, l'ingresso allo stomaco è chiuso dallo sfintere esofageo inferiore. Quando l'onda di rilassamento raggiunge la parte finale dell'esofago, lo sfintere si rilassa e l'onda peristaltica trasporta il bolo di cibo nello stomaco.
Quando lo stomaco è pieno, il tono del cardias aumenta, impedendo al contenuto di refluire nell'esofago.
Le fibre parasimpatiche del nervo vago stimolano la peristalsi dell'esofago e rilassano il cardias; le fibre simpatiche inibiscono la motilità dell'esofago e aumentano il tono del cardias.
In alcune condizioni patologiche, il tono del cardias diminuisce, la peristalsi dell'esofago viene interrotta - il contenuto dello stomaco può essere gettato nell'esofago (bruciore di stomaco).
Un disturbo della deglutizione è l'aerofagia, ovvero l'eccessiva deglutizione di aria. Ciò aumenta eccessivamente la pressione intragastrica e la persona avverte disagio. L'aria viene espulsa dallo stomaco e dall'esofago, spesso con un suono caratteristico (eruttazione).